
C’è sempre stato come un vizio di forma nei film di Paul Thomas Anderson. Da un lato (nell’accezione più forte di “vizio di forma”) una tendenza a debordare i confini del racconto, a catastrofare la narrazione e piegare i personaggi, che in Inherent Vice (Vizio di forma, 2014, tratto dal romanzo omonimo di Thomas Pynchon) diventa più radicale, e dall’altro (nell’accezione più debole), soprattutto in Boogie Nights (L’altra Hollywood, 1997)e Magnolia (1999), un vizio nella forma, una certa acerbezza combinata con un carattere che vuole introdurre il nuovo. Inherent Vice sposta e condensa questo vizio di forma in cui Anderson salva l’elemento di avventura che ogni indagine comporta – in fondo è anche una detective’s story – senza fare dell’indagine una semplice avventura, come avviene nell’“operazione” che ha successo ma non porta a compimento di Birdman (2014).
Dentro Inherent Vice c’è sia un lavoro sulla condensazione che sullo spostamento, che certo ha che vedere con il pattern dell’indagine – tra l’altro (rimando intertestuale) già il noir e soprattutto il poliziesco incentrato sulla figura del detective hanno una “trama” complessa e intricata, «une intrigue particulièrement complexe», dicevano Borde e Chaumenton del noir – che funziona non tanto semanticamente (che cosa significa?) ma sintatticamente, come una topografia dedalica, labirintica, fatta di condensazioni e spostamenti, come la Roma di cui parla Sigmund Freud al tempo stesso e nello stesso posto: antica, medievale, rinascimentale, barocca e odierna.
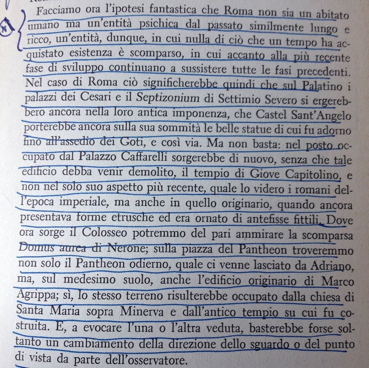
“Doc” Sportello non si lava molto ma non è selvaggio e brutale come Mickey Spillane, ha una (sua) moralità, è più chandleresque, come il racconto.
In Inherent Vice le regole (figurative, narrative) sono fissate ma, al tempo stesso, incessantemente schiodate, il ritmo integrato con il modulo, il tempo con lo spazio, la narrazione con il significato, non ancora, o non così, nei primissimi film.
Boogie Nights è una costellazione di dolly, lunghi pianisequenza, dissolvenze incrociate e in nero, ralenti, semipanoramiche a “schiaffo”, split-screen, mascherini, il cui racconto è organizzato attraverso il modulo narrativo altmaniano, sviluppato massimamente nel mosaico di Magnolia. Il film si compiace di un certo gusto per il pittoresco, l’artificio e l’effetto, segno di una ancora acerba capacità di organizzare sia il discorso narrativo ma soprattutto il suo intregrarsi e prendere corpo nella figurazione.
Il repertorio sprigionato in Boogie Nigths comincia parzialmente a distendersi in Magnolia. Ci sono ancora molti carrelli (o forse si tratta della steady-cam) a seguire il gesto e l’azione dei personaggi, per dirigere gli attori anche “in macchina”, accompagnarne e sospingerne il movimento e, al tempo stesso, spingere fuori un personaggio per farne entrare un altro, la macchina è spesso in movimento e molti raccordi, oltre che sugli oggetti, sono in movimento, sulle brevi panoramiche “a schiaffo” che rendono la struttura narrativa un girotondo, una sorta di roulette, un “sotto a chi tocca”, come nel quiz televisivo. Ma poi Anderson sa anche fermarsi e sostare, sospendere il vorticare dei flussi narrativi che in Boogie Nights erano più un coro e che in Magnolia si intersecano fra loro come in un mosaico vertiginoso che, attraverso un montaggio che è sia alternato (gli eventi si svolgono simultaneamente e sono sempre in qualche modo collegati attraverso un personaggio che apre la scena ad un altro) che parallelo (le storie sono comunque differenti e parallele ma legate da un’idea comune e raccordate tra loro da alcune “idee di regia”), accumula materiali incadescenti, residui lavici, detriti, emozioni, pulsioni che infine si sprigionano catastroficamente in un’apocalisse – la pioggia di rane – che, insieme, annienta e redime. Nel punto di massima rottura e ebollizione, quando le strutture collassano, sfaldate nelle loro supposte identità, drammaticamente, quando i corpi crollano sull’orlo della morte, sostano sulla soglia che sottilmente congiunge e disgiunge vita e morte, feriti, i corpi possono aprirsi gli uni altri, nell’isteria, nella crisi, nel pianto, al cospetto del trauma, facendo esperienza, aperti nei loro vizi che ne schiantano le forme peraltro deboli, inclusa la corazza nera e muscolare di Tom Cruise. Anche nella sua forma c’è un vizio, una debolezza, un punto cieco. La catastrofe apre al mondo, le porte si aprono quando si cade a terra spaccandosi i denti, nella ferita e nel sangue, gli uni si aprono agli altri. Allora il rimando non può essere al solo Altman, ma anche a John Cassavetes, il cui cinema è un disfarsi della storia, un annodarsi e snodarsi di corpi che vacillano, urlano, piangono, saltano, vivendo un’esperienza interiore, una messa alla prova, un viaggio ai limiti di corpi isterici, istericamente gioiosi, caduti a picco (giù da una scala, lungo un crinale), sfatti dalla malattia, bagnati di piscio, persi… e, dunque, ritrovati, come la pistola smarrita che cade dal cielo. Corpi ubriachi d’amore e avvinghiati nell’amore, come in Punch-Drunk Love (Ubriaco d’amore, 2002).
Punch-Drunk Love è comunemente considerato più involuto rispetto ai precedenti, perché la “storia”, l’intreccio è meno complicato e solitamente ciò di cui siamo consapevoli di un testo o un’opera, come scriveva Northorp Frye, è proprio quel raggruppamento di fatti e scene che chiamiamo storia. Boogie Nigths era una fiaba con più passi (svolgimenti) che precipiva in una sorta di cuspide, Magnolia un intrecciarsi di passi che debordava e ramificava il testo filmico in più fiabe tra loro collegate, anche dalla canzone che tutti i personaggi ad un certo punto cantano: Wise Up.
Ma in Punch-Drunk Love la narrazione, per quanto più “semplice”, si fa ancora più sottile e piegata. Per dirla con Frye, le erbacce e le pietre (narrazione) che corrono via mentre la nostra focalizzazione è centrata sugli alberi e le case (intreccio). È una fiaba in cui i passi seguono l’uno all’altro muovendo prima da una mancanza (la solitudine del personaggio interpretato da Adam Sandler) a cui corrisponde il passo di collezionare i punti dei budini per viaggiare attraverso il mondo, e dopo da un danneggiamento (l’aggressione alla fidanzata) a cui segue un altro passo (l’affrontamento del piccolo villain interpretato da Philipp Seymour Hoffman). Il racconto prende avvio dalla mancanza e dalla sciagura, direbbe Propp. L’eroe viene invitato: Adam Sandler riceve molte telefonate e visite dalle sette sorelle che gli ricordano di partecipare all’invito ricevuto per la festa di compleanno di una delle sorelle. L’invito è come un ordine.
La narrazione in Punch-Drunk Love è più integrata con la struttura compositiva del film. La narrazione prende sempre più corpo nella composizione. Le idee diventano sempre più idee di regia e il significato ormai non è disgiungibile dalla costruzione del testo filmico. La sintassi è già semantica, come dice Lotman: il segno simula il proprio contenuto. Non c’è un confine netto tra sintassi e semantica e Punch-Drunk Love disarticola proprio i confini.
Il film è fatto di inquadrature decentrate, spazi vuoti e desertificati, il personaggio interpretato da Adam Sandler è ancora più spaesato e “straniero”. È come se né l’occhio né il racconto, né tutto il repertorio di Boogie Nigths (qui parzialmente scarnificato) né le strutture narrative corali e a mosaico dei due precedenti film potessero contenere gli spazi ridisegnati dalla luce, elevati al mistero, incarnazione di un vuoto potente e perturbante, come se alla superficie delle cose fosse restituita la sua potenza.
Nella prima inquadratura decentrata Adam Sandler, vestito di blu, è come rinchiuso in cantuccio, ranicchiato in un angolo, incavato nel silenzio del mondo, una creatura prigioniera di una caverna, assegnata solo al brusio della sua voce, una voce umana che disperatamente urla silenziosamente, bofonchia drammaticamente un appello come nel lungo pianosequenza della telefonata al centralino erotico. C’è una risonanza con la prima inquadratura del primo film di Anderson, Hard Eight (1996), in cui ll quadro fisso hopperiano, asettico, freddo è subito mosso. Da sinistra entra un camion che attraversa l’immagine e dall’angolo destro più “vicino” allo spettatore la macchina da presa si muove accompagnando il movimento di Philip Baker Hall fino a quando non si ferma davanti a John C. Reilly accovacciato sul marciapiedi e schiacciato sulla parete bianca.
Gli schemi di rappresentazione e i moduli narrativi srotolati, a volte con una certa disinvoltura, dei due precedenti film non possono più essere dispiegati in questo caso, come se quei dispositivi, pur sempre di cattura, si fossero come prosciugati dinanzi alla crisi di un personaggio caratterizzato da continui “traumi testuali” (le sue improvvise incandescenze), spaesato e perso in un paesaggio solitario, come in certi piani di Michelangelo Antonioni. Sandler non può dimorare nemmeno nella propria casa, sempre irrequieto, come nel pianosequenza della telefonata intensa, comica e, insieme, drammatica. La macchina da presa (spesso una steady-cam), come in Magnolia accoglie, accompagna, tampina l’azione o, meglio, il gesto dei personaggi che si muovono negli spazi che a volte si fanno dedalici, labirintici, kubrickiani, come quando Sandler si perde nel residence di Emily Watson, o nella scena della prima aggressione, quando la fuga hitchcock-wellesiana di Sandler trans-muta in un movimento di mondo che riconfigura gli spazi disegnando una topologia dello spavento e dello smarrimento che culmina nel bianco abbacinante che dilava tutti i tumulti in un’immagine di pura angoscia. Il movimento del personaggio e la luce conferiscono un nuovo senso agli spazi facendone delle dimensioni altre, in cui spesso Sandler incorpora alcune figure dello spaesamento: di volta in volta catturato e assorbito, inghiottito e isolato. Un’architettura emotiva fatta di segni del transitorio, dell’abbandono e dell’attesa, come le strade di una Los Angeles di periferia inabitata e un po’ fatiscente. Inquadrauture riempite di vuoto, nell’alba di una solitudine spalancata sull’abisso di un paesaggio senza riferimenti e cornici. Luoghi inabitati in cui Sandler non è di casa, che abita senza dimorare, in cui si perde, è come ingorgato, chiuso nel vicolo della fuga, nemmeno nel suo rifugio è protetto dai rumori, dalla luce, dagli incontri, dagli incidenti (anche nel magazzino il suo assistente cade dalla sedia, lui stesso inciampa, i bancali rovinano dai muletti). Stazioni di un’appartenenza sempre più precaria, di un radicarsi effimero. Sandler prende posizione in un’inquadratura sbilanciata (si pensi all’incipit), in cui il suo isolamemento nella parte sinistra dell’immagine “pesa” nel contrappunto con il vuoto della parte destra, e la condizione distributiva non è centrata – come accade stucchevolmente nei film di Wes Anderson – e tale composizione sbilanciata suscita un’impressione di accidentalità e transitorietà, anziché sull’equilibrio, Paul Thomas Anderson spinge sull’instabilità. Un campo di forze, come ci ricorda anche il teorema di Earnshaw, non può mai mantenersi stabile, solo la morte, il freudiano ritorno alla materia inorganica è stabile. Sandler fluttua perché instabile, come nella corsa dentro il bianco che rarefà la saturazione di violenza, quella muta dell’impotenza. Il suo personaggio non abita gli spazi perché assente a se stesso.



Si tratta di spazi luminosi e di luce che si fa spazio. La luce e i colori giocano un ruolo nodale, ancor più che in Boogie Nights e Magnolia più complessi nell’intreccio piuttosto che nella narrazione, ma meno ambiziosi sotto questo profilo. Un’ottica goetheana: il blu del vestito di Sandler (o della fascia di vernice della prima inquadratura) e il rosse del vestito di Emily Watson, colori fisici che nascono dall’interazione dei contrari, luce e tenebre; e il bianco, colore chimico che oggettiva: la fuga dinanzi al mondo (anche i personaggi di Boogie Nights e Magnolia fuggono e Inherent Vice è tutto una fuga) o la scoperta dell’amore, l’emozione in cui si incontra il mondo.
La luce che diventa bianca, la luce che si dissemina nei colori informi degli intermezzi, quasi dei “traumi” à la Jordan Belson (in realtà di Jeremy Blake) – i traumi della pioggia di rane in Magnolia e qui dell’apparizione dell’harmonium che fa entrare la musica nella sua vita e i traumi di Ineherent Vice: la botta in testa, l’urlo improvviso i Joaquin Phoenix. Ma più in generale i traumi testuali sono catastrofi, punti critici, punti di rottura che biforcano la scelta e che non sono affatto soverchiate da configurazione caotiche e disordinate. L’inversione della curva ascendente di Mark Whalberg in Boogie Nights, la struttura a farfalla (butterfly effect) di Magnolia (il cui incipit didattico è quasi un breviario della teoria delle catastrofi), che introduce differenziali a volte anche minimi in un punto del sistema ma che hanno ripercussioni su tutti gli altri punti, che infine culminano nella catastrofica pioggia di rane. L’instabilità è una diversa configurazione del sistema.
La luce e il rumore. Gli intermezzi sono altri traumi, “rumori”, che inframezzano il racconto. La luce interagisce con l’oscurità, sulla soglia tra luce e oscurità in cui sosta Adam Sandler, in bilico tra l’interno buio della suo rifugio e l’esterno luminoso, strappato dalla sua nicchia dallo schianto, dall’urto e dal rumore: il film è segnato da rumori, incidenti, gesti violenti e “aggressioni”. Il paesaggio stesso è rumore che spalanca il silenzio del personaggio. Il rumore schioda il silenzio e mette in movimento il paesaggio (quando Sandler sta per vivere il suo primo decollo sente subito un rumore), l’harmonium – quasi un mezzo magico, un dono – porta la musica. Il rumore dei passi della folla che improvvisamente appare quando Sandler e la Watson si incontrano nell’hotel alle Hawaii, l’immagine diventa un campo di forze, un caos, un tumulto, un trafic alla Jacques Tati (il cui nume tutelare è disseminato qua e là nel film, per esempio quando Sandler si perde nel residence) che rompe l’equilibrio della stasi. Rovesciando il principio di Rudolf Arnheim, non ci sono due forze di intensità uguale che agiscono in direzioni opposte (definizione di equilibrio), ma due forze di intensità diseguale che agiscono nella medesima direzione.

L’indagine di Adam Sandler, il suo allontanarsi da casa – questa volta senza essere invitato – per andare alle Hawaii a cercare la sua fidanzata e nello Utah per affrontare il cattivo, come accade a “Doc” Sportello nel finale di Inherent Vice, finalmente incontra la luce. La luce blu del dialogo in auto tra la Watson e Sandler. La luce del sole che entra nel magazzino. Il reciproco innestarsi l’una nell’altra di luce e oscurità del finale e soprattutto la luce intesa come la concepiva Goethe, come qualità che conferisce una tonalità soggettiva ed emotiva. Ma pure la luce come disturbo, rumore, lens flare – prima dell’utilizzo che ne farà J.J. Abrams – che è comunemente considerato appunto un “rumore”, un errore, un vizio di forma, una piega direbbe René Thom, qualcosa che non conchiude il quadro, che non permette alla struttura di chiudersi, né ai corpi di chiudersi gli uni agli altri come alla luce di penetrare nel bunker di Adam Sandler. Altrimenti il tracciato sarebbe sempre costante e continuo, regolare e definito, cioè nulla accadrebbe. Forse così si spiega la scelta dei moduli narrativi di Boogie Nights e soprattutto Magnolia, strutture spettacolarmente più adatte a rappresentare quell’evento, quel cambio di direzione, quella catastrofe che modifica l’andamento del racconto che in Punch-Drunk Love è innescata non da un’inversione o da un effetto farfalla, ma dalla piega: un traboccare sul bordo, un bordeggiare tra il buio e la luce, come curva di contaggio tra la caverna e lo spazio aperto. In ultima analisi, un’instabilità introdotta da equazioni differenziali che dipenda dai parametri che appaiono nelle equazioni stesse, nello stile di regia di Paul Thomas Anderson. La materia in situazione di equilibrio, ha scritto Prigogine, è cieca, al limite vede sole le particelle circostanti e più prossime, mentre lo squilibrio porta la materia a vedere e a biforcarsi. Proprio la biforcazione, con i suoi possibil passi, conferisce a un sistema il suo racconto. C’è racconto (un’evoluzione, una storia che si biforca) nei film di Paul Thomas Anderson perché c’è un sistema (una struttura entropica che consuma energia debordando i confini del racconto).
Punch-Drunk Love è una morfo-genesi, il racconto della nascita di una nuova forma di vita che si dispiega da una piega, dal prendere piega di un cambiamento che curva la materia. La materia si incurva catalizzata dall’apparizione disturbante e aggressiva di Emily Watson: prima lo avvicina con l’inganno e dopo lo inchioda suo malgrado ad un appuntamento. Lo spazio vissuto di Sandler, curvandosi, piegandosi, diventa così materia d’espressione e Paul Thomas Anderson curvando la tessitura del racconto ne fa a sua volta materia d’espressione. Gilles Deleuze ne La piega, commentando Leibniz, il filosofo della piega, ha osservato che la «piega di materia o di tessitura, va messa in relazione con diversi fattori, innanzitutto con la luce, col chiaroscuro, col modo in cui la piega cattura la luce, a seconda dell’ora e dell’illuminazione»: è la sinossi di Punch-Drunk Love.
La luce e i corpi. Il blu può essere il colore della solitudine, della smaterializzazione, come in Yves Klein, ma in Klein il blu è anche il colore di una vita pur sempre vissuta, anche se nell’etere. Anche il bianco può rappresentare il culmine della fuga dal mondo oppure la purezza dell’amore come nel risveglio dopo la prima notte d’amore.

Un lens flare blu riga il finale, l’integrarsi di luce e oscurità e l’abbraccio dei due corpi (“eroici” come il Peter Pan o lo Spider-Man della canzone “Save Me” che chiude Magnolia), uniti dall’amore, come nel finale di Magnolia e Inherent Vice. Come in Goethe, i corpi vedendo la luce si fanno a loro volta luce. E possono sorridere i sorrisi del mondo dopo averne pianto le lacrime.


«Verrebbero di notte a provarti nella lotta,
trascorrendo la casa come furie,
afferrandoti per crearti
e strapparti alla forma che ti chiude».
R.M. Rilke, L’angelo
Dopo le lacrime e i sorrisi, il sangue. In There Will Be Blood (Il petroliere, 2007) – fino a questo punto l’opera più ambiziosa nella filmografia di Anderson – Daniel Day-Lewis, il petroliere, è una forma chiusa. Scava la roccia, penetra, discende nelle viscere della terra, come fa la macchina da presa di Anderson: uno scavo nella roccia animalesca del personaggio chiuso nella sua corazza a dispetto delle ferite e delle ammaccature. Ancora una caverna oscura dopo Punch-Drunk Love, in cui la luce del sole cola a picco, come la punta della trivella che buca la testa dei minatori.
Il pozzo di petrolio si staglia contro la chiesa, quel tempio che un tempo, all’epoca dei Greci, rappresentava l’unione di arte e tecnica, cielo e terra, e che in There Will Be Blood è marcato come un pericolo e un antagonista. Il pozzo di petrolio è in competizione con la chiesa sancendo così la separazione di tecnica e arte. Nell’antica Grecia, come spiegava Heidegger, il tempio organizzava intorno a sé il paesaggio e le attività umane, tutto quanto attorno al tempio si stanziava, sostanziava, essenzializava e prendeva posizione rispetto a esso. Il petroliere vuole non abolire tale principio organizzatore e formatore del tempio, piuttosto depennare la chiesa e rimpiazzarla con il pozzo di petrolio intorno al quale costruire scuole, benessere e nuove città. A dire il vero già la chiesa dei cristiani aveva sostituito il tempio dei Greci. Mentre questo guardava sempre fuori di sé, quella guarda solo al proprio interno, con le sue funzioni che articolano le liturgie. Il petroliere vuole rimpiazzare la chiesa ritornando all’ambiziosa funzione del tempio greco. Fare un nuovo mondo muovendo dalla mano che scava nelle budelli della terra, penetrare nel suo intestino fangoso: fare un nuovo mondo nel Nuovo Mondo. L’America.
Ma il baricentro è spostato verso il basso, la gravità pesa, il film è petroso, le funi scivolano verso il basso, come in un gorgo. Il tempio dei Greci congiungeva il cielo e la terra ma There Will Be Blood è sprofondato nelle interiora della terra. Il petroliere si appoggia alla terra che è il referente del suo movimento, impiegata come potenza, una terra che è appoggio per i suoi pozzi e che li nutre di petrolio. Il cielo invece non è accessibile. Nel film appare nella luce abbacinante che taglia quasi gli occhi, nel movimento di macchina della gru il cielo è inafferrabile e lontano, il cielo è velato dalla foschia proprio mentre il petroliere conficca la terra con i suoi puntelli. Una vastità attraversata da una lama luminosa che circonda e avvilluppa quasi per assediare il petroliere e il predicatore: entrambi si rifugiano nelle loro caverne, nel pozzo e nella chiesa. La luce scende nel pozzo, filtra nelle fessure delle pareti di legno della chiesa, il cielo spalanca e divarica le inquadrature. (Per trovare paessaggi così eloquenti e suggestivi nel cinema americano occorre risalire a Cimino e Malick). Il petroliere, il signore assoluto della natura e dei destini altrui, non si staglia sul cielo, è spesso stordito e coricato, sdraiato, steso orizzontalmente, anche all’inizio, dopo la caduta, striscia sulla terra, nel mezzo del racconto, è addormentato sul pavimento di legno, e nel finale, ormai creatura mostruosa e informe, arranca sulle scale, rannicchiato, dorme sulla pista da bowling accortocciato su se stesso, sta seduto dopo essersi per l’ennesima volta sporcato le mani di sangue. La sua forma, anche se chiusa, è viziata. Mentre la piega in Punch-Drunk Love dispiegava, in There Will Be Blood ripiega.
La narrazione di Boogie Nights e Magnolia era affidata a moduli narrativi tendenzialmente atipici, quella di Punch-Drunk Love soprattutto ai patterni figurativi – era più una composizione di forma e contenuto. There Will Be Blood si presenta ancora più “semplice” di Punch-Drunk Love – se non per il fatto esteriore che si tratta di un dramma. È più lento di tutti gli altri film, ma non meditativo. Il tempo è quello della polvere ma anche dell’accumulazione. La polvere si deposita nei secoli ma a volte si impenna e soffia forte, così anche il capitalismo conosce tempi lunghi e tempi più traumatici. There Will Be Blood, coerentemente con gli altri film di Anderson a partire da Hard Eight – dall’improvvisa lite in famiglia nel bar in cui parlano Gwyneth Paltrow e Hall, sullo sfondo ma che fa sobbalzare il campo/controcampo in una rapidissima panoramica a schiaffio appena e accennata e subito rientrata, alle botte in testa al malcapitato ostaggio – è configurato come un trauma: incidenti, rotture, stordimenti, cadute, esplosioni, morti. Anderson in There Will Be Blood utilizza narrativamente la postura di Daniel Day-Lewis, scolpisce come una materia che di volta in volta prende forma, impastata con la fanghilia, la viscosità nera, scavata, rigata, sbattuta fino a deformarsi e a disarticolarsi. Nella sua postura prende corpo il capitalismo come potere che decodifica e ricodifica, un’entità bifronte che non ha confini definiti, non ha una forma, che è sempre più spaventosamente informe, come il corpo di Daniel Day-Lewis. Un vizio di forma, il capitalismo è viziato nella sua forma.
Ancora di più che non in Punch-Drunk Love, la composizione è davvero il legame tra forma e contenuto. Il contenuto della nascita del capitalismo, un trauma, si incorpora e quasi invagina nella forma della rottura così tipica del cinema di Anderson, che connota i suoi film: il petroliere si rompe la gamba, il figlio si rompe l’udito, si rompe il suo pozzo di petrolio, si rompe la falda, si rompe la testa del predicatore-commediante.
È attorno al pozzo di petrolio, non alla chiesa, che deve istituirsi il mondo nel capitalismo. Il petroliere non vuole concorrenti, il capitalismo, al di là della retorica del libero mercato e della concorrenza, è sempre stato tendenzialmente monolopolistico. Né la chiesa, né la famiglia, possono essere legami che vincolano, meglio corrompere l’una e reinventarsi la seconda. Non si tratta solo di secolarizzare la religione ma anche di oltrepassarla senza rinunciare a quelle complicità di cui la storia dei conflitti tra capitale e fede è disseminata. D’altronde pure la religione risponde adottando le stesse armi (lo spettacolo) e trasformandosi in business: Max Weber, a proposito delle sette religiose americane ha parlato di “caccia all’anima”.
Non solo nell’Europa riformata e soprattutto calvinista, come dimostrano le ricerche di Weber contenute in L’etica protestante e lo spirito del capitalismo,ma anche e, soprattutto ad un certo punto, negli Stati Uniti, il nesso religione-capitalismo era radicato e annodato. Nel 1906 Weber pubblica Le sette e lo spirito del capitalismo in cui si può leggere qualcosa che viene chiesto anche al petroliere:
Ma non basta essere battezzati: nella chiesa si nasce, alla setta si aderisce. Occorre purgarsi e purificarsi. Nella chiesa non si è ancora qualificati, nella seta si è eletti in virtù delle proprie qualità: “Sono già battezzato”, dice Daniel al vecchio proprietario dalla fattoria che galleggia nel petrolio che gli ricorda come la sua “unica via di salvezza”, cioè l’unica via per ottenere quello che vuole, il petrolio, è battezzarsi nela sangue di Cristo
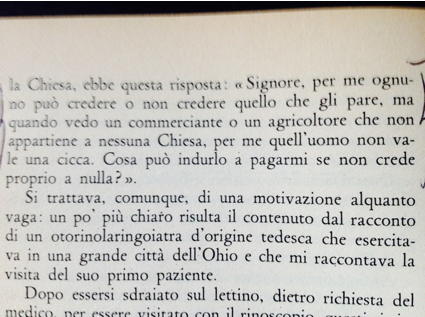
Da un lato il predicatore continua a ricordare il debito al petroliere e dall’altro il petroliere continua a non pagare il suo debito con il predicatore.
Oltre le analisi di Weber sui rapporti tra capitalismo e religione, Walter Benjamin, nel frammento del 1921 Capitalismo come religione, enunciò che il capitalismo è religione, una religione senza riposo né redenzione: solo colpa e debito. Il petroliere adotta il figlio del suo minatore morto per colpa del suo pozzo e rimane in debito di 5000 dollari con il predicatore per tutta la vita. Una religione senza un aldilà, il fuori è già interiorizzato, il figliol prodigo non può fare ritorno, è da subito un bastardo o un traditore che porta il nemico nella casa del padre. Una religione che si identifica con il culto del profitto: il petroliere lavora sempre per guadagnare. Non c’è un fuori oltre questo rito. Alcuna trascendenza, è una religione, come il film, sprofondate nei recessi della materia, ingoiata nella cavita oscura della riproduzione (come le molte dissolvenze in nero che risucchiano le immagini) che non salva né redime, nemmeno riforma come voleva Lutero, patrocinatore dello sterminio dei contadini rivoltosi. È una religione della decadenza e della rovina. Il capitalismo non salva il mondo, ma è la sua rovina.
È così, su queste nuove basi religiose che legano (religio -onis, religare: legare), che la civiltà può riconfigurarsi, perfino fondarsi a partire dal pozzo di petrolio, fondata, scavata fin dentro la struttura dei rapporti familiari (il petroliere amministra anche le relazioni infrafamiliari in cui si annunciano le politiche del fordismo che voleva famiglie tranquille in cui i lavoratori potessero trovare riposo per meglio lavorare in fabbrica), dentro il ventre della terra e della famiglia a sua volta, se necessario, sostituita con identità fittizie, dalla fondazione di nuove famiglie che non siano quelle naturali che impacciano e inciampano il processo di formazione del capitalismo. All’inizio il pozzo entro cui è inghiottito il petroliere è solo un’enclave che via via dà forma al capitalismo che, dopo aver decodificato e deterritorializzato (opponendosi alla superstizione della fede), codifica e riterritorializza, introiettando il fuori. Un piccolo pozzo, immerso in una landa ancora selvaggia e senza proprietà – come si vede nella prima inquadratura rocciosa – immagazzina energia fino al punto da estendersi e espandersi per affermarsi come nuovo potere, non più mitico, superstizioso e religioso. La prima inquadratura del film è un piano medio-lungo di colline petrose, lo scenario perturbante, non moderno, della nascita della modernità, in cui si inscrive la modernizzazione delle macchine. Il paesaggio più adatto sia per mostrare il potere devastante del capitalismo, sia per organizzare l’estetica dello shock così tipica dei film di Anderson. Lo schock dell’accumulazione.

Il petroliere è un cercatore, cerca nuovi giacimenti, nuovi oceani sotterranei di petrolio, accumulando terre e strumenti: è un accumulatore. There Will Be Blood, ci sarà sangue: l’accumulazione originaria è una storia di violenza, come ha spiegato Marx nel capitolo del Libro I del Capitale dedicato all’accumulazione violenta del capitale.
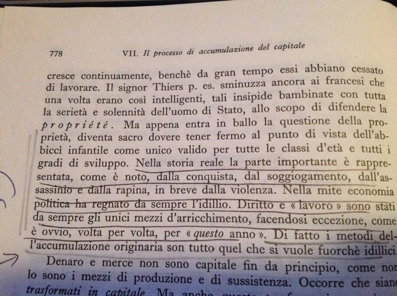
La mani del petroliere sono sporche perché suda e lavoro, impasta il proprio corpi nei fluidi melmosi, ma anche perché uccide. Zoppica perché è caduto rompendosi una gamba mentre lavorava e il figlio adottivo ha perduto l’udito (dopo aver perso il padre naturale in un incidente sul lavoro), ma rompe anche l’ossatura della vita altrui, di coloro che come lui e più di lui si sporcano le mani rompendosi la schiena, morendo, senza rompere mai la schiena altrui, né potersi costruire due piste da bowling nella propria casa su cui può spaccare il cranio del suo predicatore-complice fin dall’inizio suo complice, servo e a volte perfino padrone. Ciò che resta di questa nuova religione e delle sue “magnifiche e sorti progressive” (la scuola, il benessere), un culto che non riforma né salva, come diceva Benjamin, non sono che le rovine, i rifiuti, gli avanzi di cibo sparsi sulla pista da bowling come macerie, frammenti di una decomposizione del progetto moderno (il capitalismo) che da un lato si compie con l’uccisione del predicatore di cui il petroliere ha rilevato (conservato e superato) la funzione e dall’altro con lo sfarsi del corpo a terra di Daniel Day-Lewis ridotto anch’esso ad un ammasso afflosciato che ha letteralmente finito: “Ho finito…”.

Ancora un corpo in The Master. La postura incurvata e la smorfia del viso di Joaquin Phoenix sono il segno di una forma inarticolata, quasi informe, che fa resistenza e tradisce il pensiero del maestro. Parte, fugge, evade, attraversa l’orizzonte con la moto rubata al maestro, penetrando così in un’altra vita che non è quella di un passato remoto raccontata dal maestro, né quella del sentiero della salute prescritta dalla fedele moglie del maestro. A modo suo, Freddie (Phoenix) supera la linea dell’orizzonte.

The Master è ancora una volta una fuga, una linea di fuga che inciampa la forma, il corpo di Phoenix è quasi inarticolato e informe. Nel deserto che il maestro Philip Seymour Hoffman vuole ridurre a tavola su cui incidere il proprio gesto, Phoenix traccia una linea di fuga, una cartografia eccedente e centrifuga rispetto ai libri del maestro. Poi non si fugge mai se non per incontrare ciò da cui fuggiamo, rischiando di cadere nel movimento di autodistruzione, l’alcolismo di Phoenix. La fuga è un delirio, come il disturbo di Freddie, un vettore lanciato nella polvere del deserto, una moto sul punto di schiantarsi in una nebulosa, come in una foto di Robert Frank.

The Master è costruito come un concatenamento di linee di separazione, anzitutto la separazione delle acque dalla terra, una dissociazione degli elementi che infine sboccia nella separazione tra discepolo e maestro e nella mascherata dell’insegnamento di quest’ultimo.
Il corpo di Phoenix, la sua mimica facciale, perforano quelle pareti nel cui andirivieni ritualistico il maestro tenta di plasmare e formare il discepolo. Entra nel buco temporale ma Freddie scivola, non si lascia ridurre al buco, quel sistema sociale di cui parla Gilles Deleuze, che sprofonda nel buco, nell’oscurità dell’io consegnandoci alla nostra soggettività come se fosse l’unica cosa che davvero contasse. Le pareti degli esperimenti del maestro e i loro buchi in cui inabissano i corpi, sono significazioni dominanti con cui inchiodare, fissando la sperimentazione, imponendo una famiglia e una casa. Freddie non ha territorio, è una linea di fuga, senza dimora né famiglia.

La forma traumatica e dissociata di There Will Be Blood e The Master, in Inherent Vice diventa allegoria. Secondo Craig Owens l’allegoria si nutre di rovine, è attratta dai frammenti e insiste nel gap tra passato e presente, il presente risale al passato ma infine per redimerlo. È quello che fa “Doc” Sportello: salva la sua ex-fidanzata e riconcilia se stesso con l’amore.
Inherent Vice è una strategia che accumula falde narrative trasformando la struttura (forma) in una sequenza rituale. Il racconto è come una disgiunzione sintagmatica, una catena orizzontale di eventi, non una combinazione diegetica in cui gli eventi corrispondono verticalmente gli uni agli altri. Né metafora, né metonimia, ma proiezione metaforica nella dimensione metonimica. L’allegoria attraversa e ibrida i confini: Inherent Vice è una detective story, un film sentimentale, una commedia sulfurea se non vaporosa, come un tessuto di vapori, una nebulosa soffice. «Il piano è mangiato dall’intelaiatura» (Deleuze-Guattari). Un mare di sovrimpressioni in cui le onde della memoria si confondono con quelle dell’oblio. Una narrazione che è pulsazione, poco orientata narrativamente (almeno in maniera lineare), in cui la luce precipita nel racconto fino a debordarlo. La luce rossa che evoca il volto di Shasta, blu che filtra delle finestre dell’appartamento di “Doc”, quella gialla che invade l’immagine fino a renderla informe quando “Doc” libera lo spione dalla sua condanna.



Più che un intrigo complesso, il film è una mappatura, un palinsesto, una sovrimpressione, in cui il presente scivola nel passato e viceversa, la metonimia si fa metafora. Una paratassi che giustappone senza coordinare nel modo della subordinazione.
“Doc” peregrina, si inabissa, nel mondo dei morti? Non è esattamente Orfeo. Inherent Vice è più una fiaba che non un rito, un mito. Nel film classico rito e racconto sono strettamente connessi, c’è un legame organico tra la realtà e la rappresentazione, in quello moderno il racconto è svelato come rito e il rito diviene l’oggetto del racconto, il moderno è la crisi di quel legame. Inherent Vice è qualcosa di diverso. La storia inizia distaccandosi dal rito ma è continuamente invuluppata nel rito, è rituale. Il rito continua a intravedersi in filigrana, direi in sovrimpressione.
C’è come una schizofrenia, lo smarrirsi (tutti fuggono, l’America come punto di fuga è diventata un luogo da cui fuggire) è una sorta di abitare, o quel modo di abitare. Non c’è un intento parodico, una decostruzione parodica del genere, magari à la Altman. Direi piuttosto, con Jameson, un pastiche, non un “pasticcio” (per quello si vedano altri film celebrati di questi tempi; si è parlato pure di coenismo, a me pare che “Doc” si ispiri più a Neil Young che non al loro Lebowski). Anderson ritorna nel passato, come spesso gli è capitato nel suo cinema, conferendo una atmosfera insolita e anomala al film, in cui non si vede la Los Angeles moderna, qualche edificio bizzarro, appartamenti, ville, uffici della polizia, e la spiaggia, come a sfocare la pressante contemporaneità. Inherent Vice insomma è un viaggio, anche attraverso gli stereotipi (hippies, guru, droga), in un irraggiungibile, un non più, inquisito con maschere sempre diverse (si pensi ai molteplici travestimenti di “Doc” Sportello). Più che un repertorio stilistico è un reportoriare gli stili. Che questo irraggiungibile il paradiso perduto dei drogati? L’utopia? Il classicismo?
Ancora il classicismo, come agli esordi, quasi vent’anni prima di Inherent Vice: Hard Eight. Il film è una costellazione di caffè, sigarette e bar, una composizione di primi piani, campi/controcampo, pianisequenza morbidi che accompagnano gli attori (come nei film succsessivi), un linguaggio semplice e “classico”, con una forma elegante, cool, uno stile che organizza, un savoir-faire che fa risonanza con quello del personaggio interpretato da Hall, un campione di understament anche nell’unica scena di violenza (l’uccisione di Samuel L. Jackson). Ma fin dall’inizio della carriera di Anderson, se da un lato persiste una fascinazione per il classicismo, dall’altro la forma classica si imbatte con i traumatismi piccoli e grandi della stupidità dei personaggi impersonati da Paltrow e Reilly. La forma inciampa nel vizio. L’old timer Hall è classic, come gli rinfaccia risentito il villain amatoriale Jackson, big time, come gli urla l’ossesso e casual Philip Seymour Hoffman, ma si imbatte nel vizio, che non è il gioco d’azzardo che scorre per le strade, per lo più deserte, di una Reno grigia e disabitata. Il vizio fa girare a vuoto il classicismo, questo entra in crisi, si fa statico, al più “pedagogico”, insegna qualcosa, ma le lezioni dal vero del cinema western, in cui un adulto navigato e rotto al mondo si prende cura di un cucciolo indifeso fino a farne un uomo (Red River – Il fiume rosso, 1948, di Howard Hawks può essere un modello), erano azioni che producevano la propria forma, così come quei cineasti (Hawks) creavano il loro proprio strumento. Il classicismo di Hard Eight, che si imbatte nel vizio – gli incontri di Hall con Reilly, Paltrow, Jackson – è invece una riproduzione di forme che avvolgono e fasciano il nervosismo, l’isteria e la caoticità di un mondo che non ha più l’aura del big time. Le azioni sono sorvegliate, raggelate, bloccate. Hard Eight non è ancora postmoderno ma postclassico. Ma analogamente al capolavoro postmoderno Inherent Vice, il postclassico Hard Eight tradisce (cioè traduzione, tradizione, tradimento, trasmissione)già l’effetto stilistico. La vitalità è quella della forma, dello stile, non sprigiona dall’azione. Una vitalità rappresa e coagulata da cui scaturisce un mondo di immagini e segni, quello del classicismo, che con le sue forme o, meglio, il ricordo di tali forme, maschera la dura e cruda realtà (postclassica) del vizio, ridà una certa eleganza alla decomposizione dei caratteri. Si pensi al dettaglio dello schizzo di sangue sul polsino inamidato di Hall subito – ma senza alcuna fretta – coperto allungando il bordo del cappotto, con grazia. Lo stile è nel dettaglio. Ma così cala anche il sipario, Hard Eight è l’addio all’articolazione classica dello spazio-tempo filmico.


Se è così, anche in relazione al film d’esordio di Anderson, Inherent Vice da un lato testimonia della coerenza rigorosa di un percorso che si è via via allargato e sviluppato – diventando meno nostalgico (Hard Eight) e più ironico (Inherent Vice) e dall’altrosi configura sempre più e soprattutto come un vizio di forma. Inherent Vice è un testo condensato e spostato in cui l’autore rivela tutta la sua perizia, la sua ars.
“Doc” cerca qualcosa, probabilmente il senso, e cercando si sposta da un testo all’altro, da un caso all’altro: la ex-fidanzata scomparsa, il militante afroamericano, il nazista ammazzato, il marito morto ma forse ancora vivo, la sorella del nazista che vuole scoprire la verità, il cartello indo-cinese della droga, e così via. Orizzontalmente “Doc” passa da un caso all’altro, così il senso, anche se non ancora trovato, almeno circola. Anderson condensa contraendo nel personaggio di “Doc” Sportello che funge da contrazione testuale e condensa con alcune sovrimpressioni che contrassegnano la tettonica narrativa e anche figurativa del film, abolendo la separazione tra funzione e ornamento. È “Doc” che si sposta e condensa, annoda attorna a sé gli altri personaggi e gli altri casi. La metonimia condensandosi nella sovrimpressione si fa metafora. Anderson anziché spostare “Doc”, o utilizzare slittamenti più convenzionali (vicinanze, rassomiglianze, contrasti) come in Boogie Nigths e Magnolia, condensa nella sovrimpressione immagini diverse, soprattutto i volti di “Doc” e Shasta, che altre volte appaiono come epifanie, con primi piani molto evocativi, blu e rossi che ricordano le stanze di Chelsea Girls (1966) di Andy Warhol.

Ma Anderson ha sempre avuto l’attitudine a spostare dell’energia, a passare da un’inquadratura all’altra, da una vicenda all’altra, si pensi solo a Magnolia, solo che in Magnolia la focalizzazione, l’accento era posto proprio sul passaggio, il raccordo sullo “schiaffo”. L’energia si spostava e si accumulava via via, transitando da un raccordo sullo “schiaffo” ad un altro, oppure prolungadola attraverso alcuni richiami (raccordi sugli oggetti). Inherent Vice tende a spostare più sul posto, un superamento sul posto che colloca il film non solo molto più in alto nella sua filmografia ma perfino in una posizione eccedente e centrifuga.
Come dice anche Metz: la condensazione è uno spostamento. I percorsi confluiscono condensandosi nel personaggio di “Doc”, ancora una volta, dopo There Will Be Blood, Anderson impiega massimamente il personaggio non solo come funzione narrativa ma pure in quanto principio (dis)organizzatore del racconto. Ciò che stupisce e meraviglia nel film è proprio questa compressione: «l’intensità di tutta una serie di pensieri può a un certo punto concentrarsi su di un unico elemento rappresentativo», dice Freud ne L’interpretazione dei sogni. In Inherent Vice c’è un passaggio e c’è un incontro, una condensazione e uno spostamento, una sovrimpressione e una catena orizzontale e perfino “letterale” o materiale. Il che ha che vedere anche con la materia che seduce, il rifiuto seduttivo che corrisponde agli strati più profondi e infantili della nostra esistenza, con l’attrazione verso il basso che, come spiega (e vuole) Freud, la cultura rimuove e sublima: sto parlando soprattutto dei piedi sporchi di Joaquin Phoenix che meriterrebbero una trattazione a parte o almeno una nota a margine: margini – della filosofia.
Anderson combina elementi diversi tra loro e poi sposta il private eye da un sostituto del vero contenuto (Shasta e forse la redenzione del suo stesso passato) all’altro. Ma in ultima analisi tutti gli spostamenti, le indagini, i casi, le storie, si condensano nel punto nodale rappresentato da “Doc”.
Quando il film comincia, “Doc” è coricato, disteso sul divano e Shasta si manifesta quasi come un’apparizione traumatica. Un sogno. Il contenuto manifesto è la soluzione di un caso, ma quello latente, la conquista della principessa.
L’indagine di “Doc” è l’indizio che il critico deve seguire per interpretare il film. Quando ritorna al passato, a quel giorno di astinenza, magia e pioggia, scopre un gap, una differenza: hanno costruito un edificio (la sede dell’associazione dei dentisti sessuomani e tossicodipendenti presieduta dal non-aggettivabile Martin Short). In fondo l’allegoria di un testo orienta sempre il proprio commento che è una sorta di feedback, come direbbe Gregory Ullmer, una riserva energetica ancora disponibile. Questo vale sia per “Doc” che per i suoi spettatori: entrambi “scrittori”.
L’energia di “Doc” è di consumo: è un consumatore di droghe. A questo punto sarebbe interessante leggere il rapporto che congiunge e disgiunge il suo corpo con quello di Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood. Rimaneggiando alcuni concetti di Marx, Deleuze e Guattari, Rosalind Krauss, potremmo dire che nella postura di Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood prendeva corpo il movimento destinato a riprodursi indefinitamente e sempre uguale a se stesso della macchina celibe (il petroliere non è sposato e nemmeno ha rapporti sessuali), più nell’accezione di Krauss che non in quella di Deleuze e Guattari. Impermeabilità nei confronti dell’esterno, perfino della famiglia, è un sistema chiuso che interiorizza il fuori, come il capitalismo, un meccanismo che riproduce il già prodotto. Il corpo di “Doc” ogni tanto è invaso da una macchina paranoica (nell’allucinazione di “Bigfoot” che gli parla dal suo televisore): quando il corpo senza organi eminentemente improduttivo di “Doc” non sopporta più le macchine desideranti che sono binarie: o hippie o borghese. Salvo poi, patologicamente, oscillare tra l’uno e l’altro come il poliziotto Josh Brolin che per uno spot commerciale interpreta un figlio dei fiori. Il corpo di Daniel Day-Lewis, pur essendo per certi versi anch’esso un corpo senza organi, non ancora articolato e organizzato, invece si appropria e si oppone alle forze produttive fino a diventare una potenza misteriosa che emana un potere sconosciuto, diventando una macchina miracolata. All’inizio anche il cercatore di petrolio è un corpo senza organi, scende nel pozzo, si sporca le mani, si rompe una gamba. Poi via via fabbrica plusvalore e si incarna sempre più nelle macchine del capitale fisso (i grandi pozzi), registrando la terra, stendendo su tutta la produzione la registrazione: il dettaglio della firma del petroliere che contrassegna in apertura e chiusura del racconto. Capitale e lavoro si separano sempre più, il petroliere non scende più nei pozzi, progressivamente si ritira dal campo, raggira, paga quaglie per petrolio, e infine si rifugia nella grande casa vuota imponendo al figlio l’aut aut, l’oppure: o con me o contro di me. Inherent Vice è più un sia che un oppure, una voluptas, piuttosto che un numen. La libido del petroliere si è trasformata in registrazione, quella di “Doc” è consumo – anche consumo di droghe.
Consumo, entropia, divaricazione. Né “Doc” né il film giocano a vincere o immagazzinare energia (o denaro che “Doc” rifiuta). Anderson non lega, i flussi sono indifferenziati (non connette tutti i casi riportandoli al nesso), come nel primo lungo pianosequenza del film (poco più di due minuti) sovraccarico: entra la voce off di Sortilege (che pensa e narra) scollegata dal suo volto, compare il titolo, il nero si fa luce e colori e “Doc” va avanti e indietro, esita, incontra quello che sarà il suo aiutante e poi scende verso il mare. Semmai Anderson ricompone, raccogliendo, ma, al tempo stesso, lasciando dietro di se blocchi inarticolati (Owen Wilson ritorna a casa, il veliero naviga verso la sua destinazione più naturale, il poliziotto è riconsegnato alla sua disperazione…), casi che possono cadere nella loro accidentalità, giocando a perdere, a sprecare, a dissipare e a rimascherare pure il supporto: girato in 35mm, gonfiato in 70mm e riversato in DCP. Il film è girato con una pellicola usurata che restituisce l’immagine del tempo che passa, una istantanea del passato, e nel suo insieme ha un’aria demodé, direbbe Benjamin, obsolescente secondo la rilettura che Rosalind Krauss fa del concetto benjaminiano. Anderson assume l’obsolescenza del medium artistico – forma viziata – gira in pellicola, con una pellicola scaduta, poi la gonfia e, senza isolarlo in una supposta purezza, ibrida con un altro supporto (il DCP), indagando e esplorando il medium, come già aveva suggerito Benjamin, dischiudendo una nuova forma espressiva. La rifondazione del medium filmico? Sarà questo il lost paradise?
Anderson, come l’angelo di Benjamin, guarda alle rovine del passato (il noir, la pellicola, l’utopia) trasportato nel futuro dal progresso catastrofico? Certo il film in quanto, come oggetto teorico, nel suo funzionamento, nella sua macchina narrativa e nel logorarsi del corpo pellicolare abbandonato ad un passato che attende di essere salvato, è uno degli oggetti di Inherent Vice, forse l’oggetto. Autoconsapevolezza critica modernista che rasenta e forse intreccia la decostruzione postmederna. Nel momento in cui la pellicola sta per essere distrutta, diventando un oggetto da museo, un fossile, riemerge come oggetto obsoleto che redime proprio perché fuori moda. Se è postmoderno, non è quello di reazione che si limita a criticare con argomenti schematici il Modernismo e la modernità e a celebrare lo status quo facendosi marketing della differenza, ma quello decostruttivo e di restistenza.
Con Inherent Vice viola il principio di Lotman secondo cui in un’opera artistica la quantità di informazione non deve mai superare la plasticità della lingua. Anderson contraddice Lotman e fa qualcosa di molto poetico pur impiegando un vizio di forma, una struttura entropica. Anderson fa della forma un vizio. Il trauma è il vizio di forma, la significanza del gioco permutativo che schiva la tentazione consolatoria del significato e apre allo scintillare del corpo della pellicola impressionata dalle pulsazioni della luce. Ritmi, corpi e luci: Inherent Vice è il film. Un sortilegio.
Toni D’Angela
Riferimenti bibliografici
Rudolf Arnheim, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 1984
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966
Walter Benjamin, Il capitalismo come religione, il melangolo, Genova 2013
Raymond Borde, Etienne Chaumenton, Panorama du film noir américain, Editions de Minuit, Paris 1955
Gilles Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino 2004
Gilles Deleuze – Félix Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 1975
Gilles Deleuze, Claire Parnet, Conversazioni, ombre corte, Verona 2007
Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. III, Bollati Boringhieri, Torino 1980
Sigmund Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino 2001
Northorp Frye, Favole d’identità, Einaudi, Torino 1973
Fredric Jameson, “Il postmoderno e la società dei consumi”, in Hal Foster (a cura di), L’antiestetica. Saggi sulla cultura postmoderna, Postmedia, Milano 2014
Rosalind Krauss, Reinventare il medium, Bruno Mondadori, Milano 2005
Jurij Michajlovič Lotman, La struttura del testo poetico, Mursia, Milano 1972
Karl Marx, Il capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1994
Christian Metz, Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia 2002
Craig Owens, “The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism: Part 1”, October, 12, 1980
René Thom, Stabilità strutturale e morfogenesi, Einaudi, Torino 1980.
Ilya Prigogine, Le leggi del caos, Laterza, Roma-Bari 2003
Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba – Le radici storiche dei racconti di magia, Newton, Roma 2003
Gregory Ullmer, “L’oggetto della post-critica”, in Hal Foster (a cura di), L’antiestetica, cit.
Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR, Milano 2000
Max Weber, Le sette e lo spirito del capitalismo, BUR, Milano 1977
